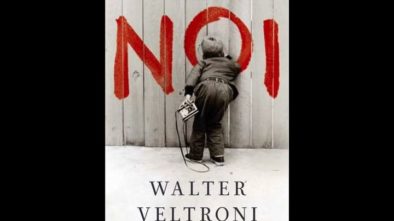Film “Quando c’era Berlinguer”
Quando c’era Berlinguer
- Scritto daMarco
- 04.2014 12:11.04
“Quando c’era Berlinguer” è il film-documentario ideato e diretto da Walter Veltroni e uscito nelle sale in questo aprile 2014.
La mia famiglia è strettamente connessa alla vicenda politica di quest’uomo. Mio nonno Bruno si trovava nella piazza di Padova ad ascoltare il comizio faticosamente portato a termine da Berlinguer, pochi minuti prima di entrare in coma e morire. Mia madre era nell’oceano di folla rossa che ricoprì Roma il giorno dei funerali.
Veltroni prosegue nel suo tentativo di recupero della memoria dei valori migliori delle due, tre, quattro generazioni che ci hanno preceduto (come nel suo romanzo “Noi” che considero il più bel libro che io abbia mai letto). E l’operazione pare difficile. A testimonianza della difficoltà il film propone nei primi minuti le imbarazzate risposte di giovani di buona famiglia e di buoni studi alla domanda “chi era Berlinguer?”
Come se il grato ricordo e l’ammirata commozione che pervase il Paese soprattutto in occasione della sua morte (avvenuta 30 anni fa esatti), non fosse riuscita a trasmettersi alle generazioni successive. Come se certi valori politici – ma anche umani, etici, comportamentali – fossero morti con quell’uomo e con quei tempi ormai alle nostre spalle, guidati dalla classe dirigente uscita dalla Resistenza.
Io, personalmente, non potrei definire Berlinguer un uomo “simpatico”. Il suo modo di parlare era “rugoso” come la sua fronte. Non sembrava mai diretto, ma sempre frutto di sofferte elaborazioni. Ma si capiva che era buono e che si batteva per qualcosa di buono. Glielo riconoscevano anche gli avversari, che per lui hanno sempre portato rispetto.
Berlinguer, lo si scandisca con grande chiarezza, era il segretario, il leader, l’anima, del Partito Comunista Italiano. Già. Co-mu-ni-sta. Pare si possa ancora dire questa parola. Un partito votato da un italiano ogni tre (nel culmine della crescita elettorale pilotata da Berlinguer). Un partito fatto di uomini e donne ispirati da Berlinguer a cui il Paese deve molto: in prima fila nelle conquiste sociali dei lavoratori (quelle che adesso, senza partiti comunisti ad opporsi, vengono risucchiate da un gorgo inesorabile), nello sviluppo culturale del Paese, nelle lotte per la pace, per l’uguaglianza, per la giustizia, per la libertà, per la democrazia.
Meglio farlo, questo elenco di lotte, perché alla domanda “cos’è per te il comunismo?” si tende a rispondere con valori opposti: oppressione, militarismo, violenza, riarmo, censura, corruzione, miseria, sopraffazione…
Questo equivoco si deve al buco nero della storia del PCI, ovvero l’alleanza con l’impero sovietico, che condivideva quel nome, quelle bandiere, quegli slogan, ma ne dava l’interpretazione più squallida a cui l’umanità abbia mai dovuto assistere. Non c’era praticamente nulla (se non qualche traccia ideologica di partenza) che accomunasse il partito dei lavoratori italiani, innamorati della democrazia e della libertà, con quell’esperienza violenta e totalitarista. Ma erano tempi difficili: tradurre il russo era difficile, visitare e capire a fondo la Russia (e la Cina, la Cambogia, il Vietnam, Cuba…) ancora di più, capire quanto di vero (pochissimo) ci fosse dietro quelle canzoni e quelle bandiere rosse è stata impresa che ha richiesto molto tempo e che, peraltro, ha visto Berlinguer in prima fila, con coraggiosi discorsi davanti ai culi di pietra dei congressi del PCUS, che gli fruttarono l’ostilità del blocco sovietico e persino un attentato organizzato a Sofia dai servizi segreti bulgari (in cui morì un uomo dentro la macchina in cui viaggiava Berlinguer, rimasto miracolosamente illeso) di cui non si parlò mai per l’imbalsamata disciplina dell’informazione che vigeva allora (nello stesso modo in cui, il suo contraltare democristiano, Aldo Moro, venne ucciso dai servizi segreti, camuffati da Brigate Rosse).
Il PCI italiano era invece apertura, onestà, progresso, tolleranza: accompagnò le lotte delle donne, delle minoranze, dei deboli. Fu modello per le amministrazioni locali e palestra di crescita per la cultura popolare. Nel film compaiono “testimonial” come Gianni Morandi, Gigi Proietti, Roberto Benigni, Giorgio Gaber, Gino Paoli, a testimonianza di uno sconfinamento anche nel pop (manca Antonello Venditti, che compose la bella “Dolce Enrico”) oltre che una situazione di quasi monopolio nel mondo della letteratura, del cinema, della musica impegnata. Il comico romagnolo Maurizio Ferrini interpretava magistralmente la semplicità sciocca e popolana di chi aveva comunque fatto – pur nella confusa povertà dei suoi mezzi intellettuali – una scelta di crescita e di solidarietà.
Nel film ci sono contributi di testimoni:oculari: cameo di dignità quello del segretario della federazione comunista di Padova e della guardia del corpo; straziante il quasi centenario Ingrao; sovraesposti quello del ministro socialista Signorile e del terrorista Franceschini; sussulto di coscienza (il suo ricordo riesce per un momento ad essere “vivo e vibbrannte” aldilà della sua solita vuota retorica) quello del presidente Napolitano, anima nera della immediata sepoltura del patrimonio politico berlingueriano, soprattutto in tema di moralità; con funzioni di raccordo generazionale quello di Lorenzo Jovanotti; asciutto e penetrante (nello stile di famiglia) quello della figlia giornalista Bianca (due dei figli si chiamano Marco e Bianca… bello!).
La “morte politica” di Berlinguer comincia con la sfilata dei 40mila a Torino. La sinistra comunista si rende conto che “la classe lavoratrice” non è più fatta solo di proletari, ma di un ceto ingentilito e moderatamente arricchito, che al suo urlo per i diritti e la giustizia ha unito un’anima conservatrice per le migliorie concesse dalla società capitalista: la possibilità di studiare, i consumi, le vacanze, il riposo, l’automobile, eccetera. Berlinguer avrebbe saputo guidare da condottiero anche questa nuova fase? Forse sì, ma gli sarebbero serviti aggiornamenti (upgrade?) veloci dei linguaggi e degli stili.
Il film finisce con il comizio di Padova. Ricordo la telefonata del mio nonno padovano a tarda sera: “Me sa che ghemo perso l’omo!” con la sua sensazione negativa che contraddiceva le primissime notizie sulla salute di Berlinguer, che invece erano confortanti.
Berlinguer parla alla folla negli ultimi giorni della campagna elettorale. L’ictus lo assale visibilmente e gli strozza la voce. La gente implora di smettere, ma lui ha ancora qualcosa da dire. “Andate casa per casa, famiglia per famiglia, azienda per azienda, strada per strada…”. L’estremo sacrificio, da combattente di pace, ricorda quello tragico del cileno Salvador Allende, che muore con le armi in mano mentre la Cia bombarda il palazzo presidenziale e il suo sogno di rivoluzione democratica. Nelle ultime parole i suoi occhi rimangono buoni e nobili e Berlinguer compone (con l’ultima intuizione di una serie infinita, 30 anni avanti rispetto all’epoca di internet) la clip con cui essere ricordato, concentrando in quelle ultime parole e in quell’ultima invincibile sofferenza, tutta la sostanza del suo essere e dei suoi pensieri.
Berlinguer muore e – aldilà del dolore per la persona – forse è meglio così. Si risparmia di vedere consumato nella volgarità il suo insegnamento; si risparmia di essere novantenne impotente dinnanzi allo sgretolarsi di ogni valore per il quale si era battuto. Ogni valore dei comunisti italiani. I co-mu-ni-sti.
.
Link consigliati:
le ultime parole del comizio di Padova https://www.youtube.com/watch?v=uXlN6GLqTeo
immagini dei funerali https://www.youtube.com/watch?v=pI5jKV8Smao
Benigni e Berlinguer https://www.youtube.com/watch?v=I_2_8hje2aE
“Dolce Enrico” di Antonello Venditti https://www.youtube.com/watch?v=-rP3S77h-tU